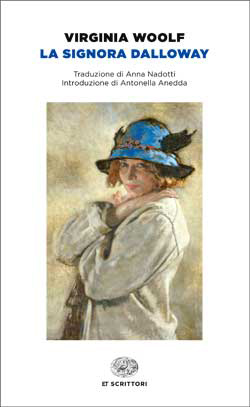Anna Nadotti, traduttrice
«Come dobbiamo leggere un libro?»
Questo si chiede Virginia Woolf in un saggio del 1925. E alla propria domanda, che dà titolo al saggio, risponde: «Non date ordini al vostro scrittore: cercate di diventare lui stesso. Siate il suo compagno di lavoro e il suo complice». Proviamo dunque a seguire il suo consiglio leggendo La signora Dalloway, il romanzo che Woolf scrisse in quello stesso 1925, e che esordisce con uno degli incipit piú celebri della letteratura moderna: «La signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comprati lei».
Dove siamo, e quando? E chi è questa signora, che cosa fa, e perché va a comprare i fiori? Lo scopriamo accompagnandola, facendoci complici di Woolf, e complici dei pensieri, dei ricordi, delle supposizioni che lei attribuisce alla protagonista del suo romanzo.
Siamo a Londra, in una giornata di giugno. E uscendo di casa insieme a Clarissa Dalloway (ne abbiamo appreso il nome e sappiamo che è «leggera, vivace, sebbene avesse piú di cinquant’anni e i capelli le si fossero imbiancati dopo la malattia»), scopriamo una città che comincia a riprendersi dalla catastrofe del primo conflitto mondiale e già mostra i segni della metropoli vitale e multiforme che sarà, che è. Il solstizio d’estate illumina e intiepidisce le strade in cui risuonano i clacson dei furgoni e delle auto, ma si sente anche il cigolio affannoso delle ruote di vecchi carretti diretti al mercato ortofrutticolo, un aereo disegna col fumo uno slogan pubblicitario che la gente dal basso cerca di decifrare, nei parchi dove la stagione ha dischiuso ogni foglia giocano i bambini e arrancano gli invalidi di guerra, sui marciapiedi muove una folla variopinta e frettolosa, mentre i negozianti di Bond Street, dove siamo giunti seguendo Clarissa, allestiscono le loro vetrine: guanti, pesci, fiori, gioielli «per tentare gli americani», dal momento che gli inglesi stanno appena uscendo da un’economia di guerra.
Nel negozio della signorina Pym una profusione di fiori, e si direbbe che Woolf indugi a elencarne le varietà anche per prendere tempo, per dare a Clarissa il tempo di pensare a come comporre i mazzi per la festa che darà la sera (ora sappiamo perché è uscita e a cosa intende dedicare la giornata), e a noi che l’accompagniamo il tempo di ripensare a ciò che abbiamo visto e udito e di prepararci a ciò che stiamo per udire e vedere: una violenta esplosione e un’auto con le tendine abbassate dietro cui si nasconde una faccia sussiegosa… il primo ministro? il principe ereditario? forse addirittura la regina?
Ognuno se lo domanda, in quel tratto di strada, e tutti provano a indovinare, compresi noi, complici di Woolf, che approfitta dello stupore generale per descrivere l’atmosfera di un’epoca di transizione, quegli anni ’20 in cui in Inghilterra si riprende a vivere la pace fra i reduci dell’orrore bellico, persone mutilate nel corpo o traumatizzate nella mente, fra nuovi edifici e residue macerie, dentro le stanze di sontuose dimore dove peraltro si risparmia rammendando i vestiti, dentro i reparti dei grandi magazzini nuovamente zeppi di prodotti coloniali. «Ma quale tragedia… la situazione dell’India!» Woolf registra piú volte i minacciosi scricchiolii dell’impero nel subcontinente indiano, dove la repressione britannica non riesce a fermare la lotta per l’indipendenza guidata dal mahatma Gandhi.
Nelle strade di Londra, Clarissa sfiora Septimus Warren Smith, «che non era piú Septimus» perché la sua mente si è smarrita nelle trincee del continente, e sua moglie Rezia, una giovane donna italiana che vorrebbe spostare all’indietro le lancette del tempo. Ma non si può, il Big Ben scandisce inesorabile l’ora e la mezz’ora. Né bastano a cambiare il corso delle cose i due minuti di ritardo con cui scocca l’ora dal campanile di St. Margaret: nei frantumi del tempo c’è spazio solo per i ricordi, che infatti non si fanno attendere, e per i presentimenti.
Fra i tanti che sentono i rintocchi, quelli piú autorevoli poi quelli piú languidi e sottili, c’è anche Peter Walsh, rientrato la sera prima dalle «lontane pianure dell’India». Sta andando a trovare Clarissa, le farà una sorpresa. Piú tardi, dopo che insieme hanno ripercorso la propria giovinezza, una lunga storia di amicizie, speranze e amori condivisi, Peter riprende a camminare per le strade e le piazze di Londra, scrutandone la bellezza mentre la luce cambia, seguendo fino a un modesto quartiere (e noi con lui) una donna «giovane, ma solenne; allegra, ma discreta; nera, ma incantevole», e interrogandosi sui propri sentimenti, di allora e di oggi. Clarissa, intenta adesso (e noi con lei) a predisporre gli ultimi dettagli della festa, s’interroga a sua volta. L’uno e l’altra, nel farlo, rivedono frammenti privati, volti che il tempo senza dubbio ha cambiato, misurano le assenze e le fragilità dovute alla guerra, si muovono nelle strade, da una stanza all’altra, da un stato d’animo all’altro, e chi legge non può che adeguarsi al loro passo, scoprendo la forza implicita in quel loro vagare. Come se si accumulasse, pagina dopo pagina, una straordinaria libertà di pensiero e di racconto, dove nulla è dato e tutto dev’essere costantemente cercato.