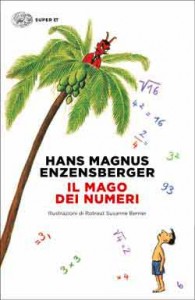Gli scienziati, perlomeno alcuni, sono persone simpatiche. Spesso, nei loro libri si trovano appelli alle cosiddette «persone normali» (quelle che nessuno di noi ha mai incontrato: qui è per intendere i non addetti ai lavori). L’idea per la prossima grande scoperta scientifica, dicono, potrebbe venire in mente a chiunque, non importa che professione svolga o quanto abbia studiato. Perciò, è importante che nessuno si perda d’animo, che la scienza torni a essere considerata qualcosa che riguarda tutti (visto che parla dell’universo in cui non solo abitiamo, ma che al tempo stesso siamo), e che manteniamo vivo lo sguardo di meraviglia che serve a farsi le domande giuste. I libri, quelli belli, fanno piú o meno la stessa cosa. Parlano della realtà, se sono onesti ci offrono piú domande che risposte, e ci insegnano a formularne altre. Ma c’è una domanda che, piú di ogni altra, l’umanità ha formulato e riformulato in tutte le epoche, da tutti i punti di vista e attraverso le discipline piú varie: anche a questa, né i libri né la scienza sono ancora riusciti (per fortuna!) a rispondere in modo soddisfacente e definitivo. La domanda è: che cos’è la realtà?
Per Primo Levi, chimico, la realtà è prima di tutto la materia che abbiamo sotto gli occhi: dura da lavorare, a volte ingannevole, ma in fondo rassicurante, poiché formata da mattoncini certi, gli elementi della tavola periodica, sui quali nessuno potrà mai appiccicare opinioni personali o politiche, come faceva invece con lo Spirito il fascismo di quegli anni. Il sistema periodico è l’analisi, scientifica e poetica, del mondo cosí come una coscienza l’ha percepito: la coscienza di un autore che accomuna i gas rari, quelli che reagiscono malvolentieri con gli altri elementi, ai propri parenti ebrei piemontesi, comunità che parla un dialetto in cui convivono le sacre scritture e il turpiloquio contadino; il ferro da ricreare in un laboratorio gelato dalle leggi razziali diventa per lui assimilabile alla scorza di un partigiano pieno di vita, il suo amico Sandro Delmastro; e l’epopea di un atomo di carbonio è qualcosa di cosí mozzafiato da sembrare piú vicina a una favola che alla realtà – ma non c’è nulla di inventato, solo scienza, restituita al lettore in tutta la sua poesia da una coscienza precisa e straordinaria come quella di Levi.
Certo, Levi era uno scienziato vero, nel cui mondo c’è ben poco spazio per fatti non verificabili: e per fare gli scienziati, bisogna essere bravi in matematica, altrimenti sarebbe come essere uno scrittore senza penna. Però, la matematica è difficile, per capirci qualcosa bisogna proprio essere intelligentissimi, e chi non è portato è meglio che si dedichi a qualcos’altro: o almeno, cosí ci ha sempre detto un certo tipo di scuola. Ma ne siamo proprio sicuri?
Non la pensa cosí Il mago dei numeri, che nel romanzo di Hans Magnus Enzensberger appare in sogno a Roberto, uno di quegli studenti che coi problemi di scuola non è mai riuscito a raccapezzarsi. Dei numeri, il mago conosce tutti i segreti (anche perché forse li ha inventati), ma sa anche che la maggior parte dei grandi scienziati non era affatto brava a fare i calcoli. Notte dopo notte, il mago svela al ragazzo che la matematica ha piú a che fare con lo stupore e l’armonia del mondo che non con «Pierino mangia una mela… quante mele gli rimangono?» Lo zero, per esempio, è un numero raffinato, e a pensarci fuori dalle ore di compito in classe, è abbastanza pazzesco che gli uomini abbiano trovato un modo per scrivere «il niente». Questo ormai classico della letteratura per ragazzi è anche una lettura meravigliosa per gli adulti: intriso di sapienza e giocosità, riaccende la passione non solo per una disciplina apparentemente ostica, ma per lo stesso universo, di cui i numeri sono sia i mattoni costitutivi sia la rappresentazione, e che è costruito in modo cosí armonico da sembrare una danza magica, in cui 11 x 11 fa 121, 111 x 111 fa 12321, 1111 x 1111 fa 1234321, 11111 x 11111 fa 123454321… e cosí via, all’infinito.
A vederla bene, quindi, la matematica non è una cosa da persone del tutto serie. E questo lo sa bene Chiara Valerio, che in Storia umana della matematica ripercorre le vite di sette matematici, sei veri e uno finto, alla ricerca del granello di follia che ha fatto votare tante vite a questa «scienza esatta dell’invisibile». In termini di salute mentale, qui i conti non tornano: non per Bolyai, il geometra, che sfida a duello tredici ufficiali, e nelle pause tra un duello e l’altro suona il violino; o per Alan Turing, considerato l’inventore dell’informatica, che dopo una vita a desiderare di essere una macchina, si suicida mangiando una mela avvelenata. Ma piú assurda ancora è la realtà, che alla fine è la piú incredibile forma di fantascienza. Prendiamo la cosa piú stabile che ci venga in mente, per esempio la sedia su cui siamo seduti o il pavimento su cui siamo appoggiati: in qualche momento della storia dell’umanità, per inventarsi una sedia stabile o un pavimento piatto, gli uomini hanno usato la geometria di Euclide, quella che tutti noi abbiamo studiato a scuola. Il punto, la linea, il piano… Tutto si basa su un’unità di partenza, il punto, che non ha nessuna dimensione. Quindi, diremmo noi, se non ha nessuna dimensione, allora non esiste. E infatti non esiste, eppure tiene insieme tutto il resto. E senza di lui che esiste però non esiste, non esisterebbero nemmeno tutte le altre cose con delle dimensioni visibili: questa sedia, questo pavimento, i computer, questa pagina web…
Non c’è scampo: anche a voler cambiare livello di ingrandimento, incontreremmo solo delle cose piú strane. Cosí strane che per descriverle l’uomo ha elaborato due modelli, la meccanica quantistica e la teoria della relatività, che sono in conflitto tra loro, eppure sono veri tutti e due. È quello che ci racconta Brian Greene ne L’universo elegante: se Levi avesse potuto fare un salto dentro la sua rassicurante tavola periodica, avrebbe scoperto che tutto ciò che sembra stabile, non è stabile per niente. Anche se potrebbe non sembrare, la verità è che in questo universo è il vuoto che crea il pieno, che la gravità può acchiappare anche i raggi di luce, e che tutto vibra sulle note di una musica invisibile che ci crea in continuazione. È la teoria delle superstringhe, finora l’unica in grado di conciliare relatività e meccanica quantistica, che Brian Greene ci racconta come se fosse la cosa piú facile del mondo (alla fine, siamo fatti di superstringhe anche noi che leggiamo), con il suo talento eccezionale di divulgatore e di scienziato.
Ma quindi, come raccapezzarsi in questo mondo in cui ogni risposta viene immediatamente smentita da una nuova domanda, e i numeri che dovrebbero portare un po’ di stabilità sono ancora piú bizzarri di coloro che li maneggiano? È questo il bello, non si sa. E finché non ci viene in mente, possiamo sempre giocare con questa grande danza cosmica, come fa Raymond Queneau: se il chimico vede e il fisico intuisce con gli occhi della mente, il poeta sente, e al tempo stesso fa a brandelli la lingua perché le parole tornino di nuovo a significare qualcosa, e i fatti possano gridare sé stessi un po’ di piú. Nelle pagine di Piccola cosmogonia portatile, l’universo si ricrea, dritto e storto come quello vero, epico come i sei canti di Lucrezio e rabbioso come un essere umano di fronte all’immensità del tutto: «La scimmia senza sforzo diventò l’uomo, che un po’ piú tardi disgregò l’atomo». E fin qui, c’eravamo anche noi. Forse, per evitare la prossima grande follia planetaria, potremmo tornare sani diventando folli del tutto, come i numeri e come gli scienziati; lasciare che la poesia e la scienza ci portino a ballare la danza cosmica, connessi col sentire delle nostre cellule e con la musica delle superstringhe che le compongono. Magari, cosí, il gioco delle domande assurde e delle risposte provvisorie tornerebbe a sembrarci divertente, e ballando potremmo davvero inciampare nella prossima grande scoperta scientifica, rallegrati dalla nostra stessa assurdità.