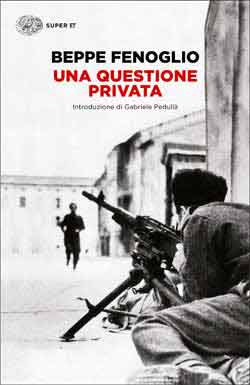L’altro giorno in un incontro a scuola, durante il famigerato silenzio seguito a «ci sono domande», il preside della scuola, che aveva assistito alla mia lezione su La casa in collina di Pavese e su Una questione privata di Fenoglio, ha preso la parola e ha dichiarato il suo stupore nel vedere come nessuno dei due autori veda riconosciuto il giusto valore all’interno dei programmi scolastici. Io ovviamente non ho le competenze tecniche per dire se questo è vero, se e come si devono rivedere i programmi ministeriali. Posso spiegare perché mi pare incredibile che due autori come Pavese e Fenoglio non siano studiati con piú cura e attenzione dai nostri ragazzi.
Mi si perdonerà, spero, il procedere quasi aforistico delle mie impressioni. Parlerò prima de La casa in collina e successivamente del romanzo di Fenoglio. Per entrambi i testi analizzerò l’incipit e l’explicit.
«Già in altri tempi si diceva la collina come avremmo detto il mare o la boscaglia». Quando hai sedici anni e sei seduto sul crinale di una vigna, sei solo con la bici abbandonata poco piú sotto e sei scappato da tutti, e inizi a leggere queste righe e di colpo capisci che qualcuno sta parlando di te, comprendi che la letteratura e i libri sono una cosa diversa da quello che senti a scuola; incidono la tua carne, colloquiano con te prima che tu fossi anche solo pensato e il grembo di tua madre ne fosse pieno.
Questo è capitato a me quando lessi la prima volta La casa in collina di Cesare Pavese, mi è sembrato allora e mi sembra tutt’ora che quel libro parli di me, mi parli di qualcosa che mi appartiene. Attenzione: con questo non voglio dire che siamo di fronte a un romanzo sull’adolescenza, ma anzi La casa in collina è il testo dove Pavese lucidamente vede ciò che sarebbe diventata con il tempo la narrazione della guerra partigiana. La trama è presto detta. L’io narrante del romanzo, Corrado, è un giovane intellettuale che si ritira in campagna non tanto per sfuggire le bombe, quanto per la difficoltà di dare seguito concreto al suo antifascismo piú teorico che pratico. Questo approccio fa di Corrado un personaggio assolutamente moderno, lui si sente non adatto alla vita attiva, allo scontro a fuoco, la sua visione della guerra è legata a un piano diverso, non tanto storico quando speculativo. Proprio questa sua distanza, che certe volte lo fa sembrare codardo, gli permette di avere uno sguardo lucido sui fatti che accadono, un occhio lungimirante come nella chiusa del romanzo in cui vengono toccati temi (la guerra civile, il rispetto del nemico, la vergogna) che solo anni dopo entreranno nel dibattito storico e politico italiano: «Ma io ho visto i morti sconosciuti, i morti repubblichini. Sono questi che mi hanno svegliato. Se un ignoto, un nemico, diventa morendo una cosa simile, se ci si arresta e si ha paura a scavalcarlo, vuol dire che anche vinto il nemico è qualcuno, che dopo averne sparso il sangue bisogna placarlo, dare una voce a questo sangue, giustificare chi l’ha sparso. Guardare certe morti è umiliante. […] Non è paura, non è la solita viltà. Ci si sente umiliati perché si capisce – si tocca con gli occhi – che al posto del morto potremmo essere noi: non ci sarebbe differenza, e se viviamo lo dobbiamo al cadavere imbrattato. Per questo ogni guerra è guerra civile: ogni caduto somiglia a chi resta, e gliene chiede ragione».
La citazione è lunga ma mi permette di fare un breve ragionamento sulla lingua di Pavese, essenziale per mettere a fuoco la sua opera. Io mi vorrei soffermare sul vocabolo «sangue». Il termine «sangue» ha una frequenza nella prosa e nella poesia pavesiana altissima; è una parola cardine, che insieme alla parola «morte», rappresenta bene molte delle tensioni della sua opera. A noi questi lemmi suonano neutri, al massimo s’avverte una leggera spruzzata di «romanticismo», in realtà negli anni in cui Pavese adopera quelle parole, il loro suono risulta molto piú connotato, perché legato alla retorica fascista e nazista: pensiamo al binomio «sangue e suolo» o all’immagine/concetto di «bella morte». Il lascito di Pavese, il suo lascito di intellettuale contro il Fascismo, sta nell’averci permesso di sentire piú questo retrogusto. La sua opposizione al Fascismo non è avvenuta nella fitta boscaglia delle colline, ma nel campo del lessico e della lingua; lui ha lottato contro la retorica del Fascismo.
Pavese ha preso quei termini abusati e triti e li ha riconsegnati a noi nella loro forma originaria, cosí da non sentire piú sulla lingua il saporaccio brutto del regime.
È anche questa una battaglia, forse meno eroica di quella che alcuni nostri nonni hanno combattuto, ma non meno decisiva. Noi siamo la nostra lingua e il lavoro di Pavese nel rendere utilizzabili concetti e idee, che altrimenti avrebbero perduto ogni ragione d’essere perché compromessi con il regime, è un lascito molto piú duraturo e profondo di quello che possiamo immaginare. Perché la libertà di parlare, scrivere ed esprimersi ha un senso se c’è una lingua che veicoli espressioni, scrittura e parole.
Se il romanzo di Pavese è un romanzo immobile, a prima lettura quello di Fenoglio è l’opposto, pieno di ricerca e di movimento; o almeno cosí ce lo presenta Calvino, quando parlando del libro fa un parallelo con l’Orlando Furioso. Il paragone tra il poema di Ariosto e il libro di Fenoglio è ovviamente interessante e soprattutto perché si imprime nella memoria di chi legge, e in un certo senso molto azzeccato per chi volesse avvicinare gli studenti alla materia del testo fenogliano. Però, a dire il vero, se leggiamo il romanzo queste affinità sono, a mio avviso, superficiali.
Prendiamo le prime righe dell’incipit. «La bocca socchiusa, le braccia abbandonate lungo i fianchi, Milton guardava la villa di Fulvia, solitaria sulla collina che degradava sulla città di Alba». Tutta la concitazione e il movimento suggeriti da Calvino con il suo paragone con Ariosto non ci sono. Anzi c’è un’immobilità ebete, un uomo guarda una villa. Una villa bellissima e chiusa dove gli è proibito entrare. Il nome del personaggio – Milton – ci porta immediatamente a pensare all’autore del Paradiso Perduto. Se andiamo avanti nella lettura delle prime 20 righe del romanzo notiamo che questa villa non è un semplice casale dell’alta langa, ma ha caratteristiche che la rendono speciale; essa rappresenta la giovinezza, l’amore, la spensieratezza in una parola l’innocenza. La villa è l’innocenza perduta che Milton osserva e che si incarna nell’amore per Fulvia.
L’amore per la donna è il vero nucleo narrativo del libro, quello che fa muovere i personaggi e la trama. In questo senso l’intuizione calviniana pare giusta; le rocambolesche avventure di Orlando e quelle di Milton sono accumunate da questa ricerca dell’amore. Ma se per Ariosto la ricerca della fanciulla è solo una scusa narrativa per produrre una serie di avventure in cui il nucleo originario della storia viene dimenticato (detto in termini diversi la furia di Orlando è una bellissima scusa per far nascere una narrazione senza un vero e proprio centro), in Fenoglio non è cosí. Fulvia è la misura di tutto, è una presenza fantasmatica, ma che domina l’intera mente di Milton tanto da diventare un sentimento che sovrasta anche l’impegno della guerra. Anzi la fine della guerra e la vittoria sul Fascismo sono soprattutto le condizioni attraverso le quali il protagonista potrà rivedere l’amata: «Il giorno stesso che la guerra finisce correrò a Torino a cercarla. È lontana da me esattamente quanto la nostra vittoria».
Mi sembra questa una notazione interessante, perché mette su un piano diverso il racconto della Resistenza da parte di Fenoglio, anche rispetto alle altre opere ora raccolte ne Il libro di Johnny. Milton alle prese con la guerra e tormentato dal suo amore per Fulvia è un personaggio molto diverso da Johnny e molto piú simile al Corrado di Pavese. Per entrambi la questione della guerra al Fascismo, l’uccisone dei nemici non hanno ragioni politiche, ma intime ed esistenziali.
In Fenoglio l’idea della perduta giovinezza e della felicità che non tornerà piú si lega al tema della nostalgia, del ritorno verso casa. Ecco quindi che quelle che per Calvino erano movimenti di ricerca e scorribande cavalleresche, nella realtà sono tanti tentativi di ritorno. Nello stesso tempo proprio i tormenti di Milton tra la sua adesione ideologica e la sua reale motivazione nella battaglia, lo rendono un personaggio che sfugge la retorica semplificatoria della lotta partigiana, e pongono non pochi dubbi su come raccontare quel periodo storico cosí complesso e frastagliato. Una questione privata, va detto, non è una storia d’amore, non è cosí che dovrebbe essere presentata; perché in realtà Fulvia non ha una valenza come personaggio, non ha spessore e profondità; non possiede queste caratteristiche perché Fenoglio non vuole che le abbia. Rappresenta un’idea, il fantasma di qualcosa che non piú: è il paradiso terreste che Adamo ha perduto.
Questo è ancora piú chiaro nel finale che leggiamo: «Poi gli si parò davanti un bosco e Milton vi puntò diritto. Come entrò sotto gli alberi, questi parvero serrare e far muro e a un metro da quel muro crollò». Ecco dopo la folle corsa, in cui Milton sembra una sorta di cavallo scosso e nella descrizione – la bocca schiumosa e spalancata, gli occhi bianchi – ricorda l’uscita di scena di Don Rodrigo nei Promessi Sposi, un muro di alberi che gli interrompe l’andare. Questo muro di alberi dove finalmente s’arresta, proprio come nell’incipit del romanzo, è molto simile al muro di piante che Dio pone a riparo del paradiso terrestre quando scaccia Adamo e Eva dopo il peccato. Cosí dove tutto era iniziato, davanti alla visione del paradiso, e della cacciata dallo stesso per l’entrata in età adulta, tutto si conclude: davanti a un muro vegetale che ci chiude la vista dalla felicità cercata, desiderata ma invano.