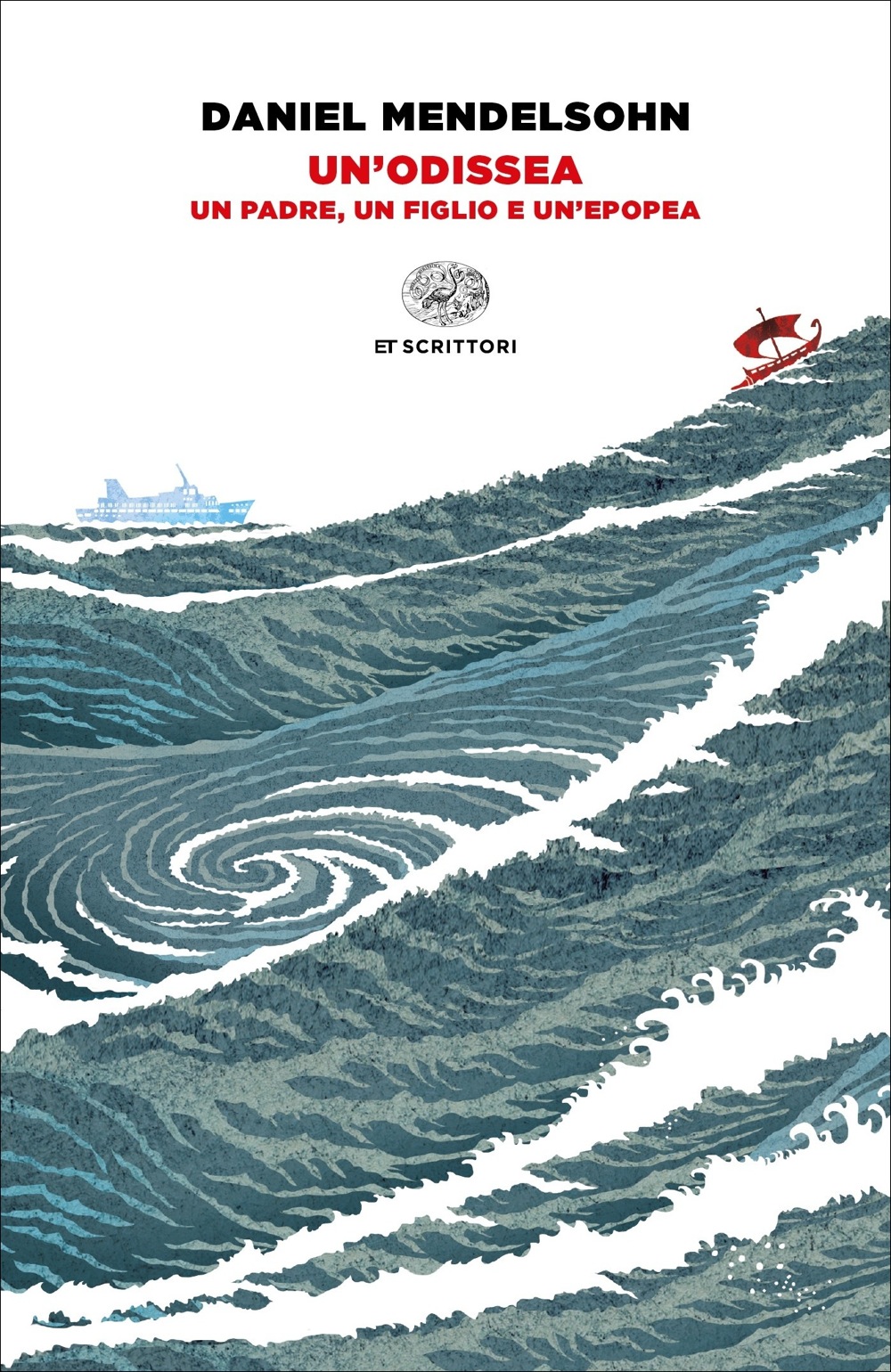Carla Palmieri, traduttrice
«E avrai capito che vuol dire Itaca».
Una sera di gennaio il signor Jay Mendelsohn, ottantunenne ricercatore scientifico in pensione, chiede di poter seguire il seminario sull’Odissea che suo figlio Daniel, docente universitario, terrà alle matricole del Bard College. Promette che in classe non aprirà bocca, ma si rimangia la parola già alla prima lezione. «Sarà un incubo», pensa costernato Daniel.
Ognuno di noi è certo di conoscere i propri genitori, ma non è quasi mai vero. Padri e madri riescono spesso a sorprenderci o, peggio, a metterci a disagio nei momenti meno opportuni. D’altronde il rapporto tra il professor Mendelsohn e suo padre non è mai stato facile: per anni ha regnato fra loro «un lungo tacere». Jay è un uomo duro, esigente, che si è fatto da sé; obbedisce a un severo codice morale, che non lascia spazio a debolezze e ambiguità. Le relazioni tra padre e figlio hanno cominciato a migliorare soltanto quando Daniel ha scelto di studiare Lettere classiche: Jay rispetta le lingue antiche e la loro grammatica rigorosa. Al liceo ha letto Ovidio, anche se ne pronuncia male il nome: lo chiama Ovvidio, il che è per suo figlio l’ennesima fonte di imbarazzo.
Il cammino dei due Mendelsohn, la loro Odissea privata, comincia cosí, con il padre che per non dover fare andata e ritorno nello stesso giorno si ferma a dormire a casa del figlio, nel letto di legno che lui stesso ha costruito per Daniel bambino. A seminario finito i nostri due eroi partiranno per un viaggio vero e proprio: una crociera sui luoghi dell’Odissea (con finale a sorpresa). Adottando la forma compositiva ad anello tipica del poema omerico, Daniel Mendelsohn narra la commovente, reciproca scoperta dei due protagonisti in una forma che mescola il saggio alla fiction e salda l’analisi del testo antico alla trama autobiografica contemporanea, dando vita e luce a entrambe. Perché l’Odissea «è anche […] una storia di padri e figli». E quando Daniel, per cui suo padre è (o è stato) poco meno di un orco, si stupisce che gli altri lo trovino «una persona squisita» o addirittura «un adorabile vecchietto», la conclusione del suo ragionamento sintetizza in poche parole il grande tema dell’identità al centro tanto dell’Odissea quanto del libro di Mendelsohn: a modo nostro, siamo tutti un po’ polytropos. Uomini (e donne) dalle molte svolte, ognuno in viaggio verso la propria Itaca.